
C’est par un soir de tristesse que j’ai écrit ce poème…
(È in una sera di tristezza che ho scritto questo poema…)
Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien, 1913
Un minuto di raccoglimento, come per un lutto collettivo.
Chiude uno dei siti più demenziali della rete, dadaista per vocazione, frequentato da sprovveduti che pongono domande dementi e da altri sprovveduti che da dementi rispondono.
Anche con punte di volgarità e diffusi problemi di ortografia.
Come faremo.
L’ultima: «ma se sono laureato in giurisprudenza e ho fatto l’esame di avvocato il titolo di dottor avvocato mi spetterebbe».
Se questo vuole farsi chiamare dottor avvocato, lasciamolo fare.
Lasciamolo fare pure se vuole coprirsi di ridicolo.
Ho detto a Irina che lo sportello della lavatrice va lasciato aperto.
Ho detto che il cestello deve prendere aria. Naturalmente il motivo non era questo, il motivo non è mai quello addotto, è che non voglio che qualcuno tocchi la mia lavatrice.
Sono gelosa e territoriale, quando voglio divertirmi un po’, chiedo a un uomo con una macchina potente se me la fa provare, l’effetto è esilarante, manco fanno finta, semplicemente, strabuzzano gli occhi, a ciascuno il suo, gli uomini, una bella cilindrata, io, il mio elettrodomestico nuovo.
Mi sono occupata della relazione con il personale domestico almeno in sei articoli, avendo appena sfiorato l’argomento.
E sono tornata in questi giorni su una bella ricerca che si occupa della bonne, che è quella che spazza, fa la cucina, vuota la cuvette e strofina l’argenteria, dalla mattina alla sera.
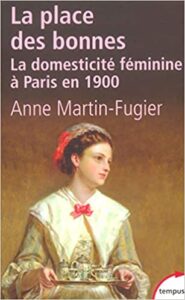
Anne Martin-Fugier, La place des bonnes
E non ha una vita propria, dorme nel sottotetto, non ha un corpo se non per i ghiribizzi del padrone, è la devozione fatta persona.
Tutto ciò nella Bella Epoque, quando la morale borghese riservava a queste donne, spesso venute dalla provincia e raccontate dalla cronaca e dagli scrittori loro contemporanei, un ruolo preciso, codificato secondo codici che andavano rispettati.
La bonne è l’esterno che si introduce nell’interno, è il fantasma che infesta ogni donna: il fantasma della serva.
Che in passato si poteva pure tenere sotto controllo, visto che una signora si definiva tale per l’assenza di contatto diretto con la sporcizia, laddove oggi più o meno tutte le donne fanno poco o tanto in casa.
(Io in casa faccio tantissimo).
Nel frattempo, c’è stata una svolta, il cui momento di apparizione sto cercando di individuare.
I rapporti sono cambiati radicalmente e sono cambiate le persone.
Dunque, quella che un tempo era la bonne adesso è diventata una donna che esprime una galassia di sentimenti.
Ha esigenze che io non posso permettermi di avere, per esempio le terme e l’affitto della casa al mare; parla sempre di sé; reclama amicizia (amicizia: io me la ricordavo diversa) a suon di messaggini; vuole caffè, stuzzichini, rompidigiuno sempre diversi; in questo senso si comporta come quei gatti insopportabili, ovvero come tutti i gatti che stanno in casa, davanti ai quali uno deve accucciarsi facendo passare sotto il loro delicato naso cibi variati, che vengono facilmente a noia; ha ubbie e nevrosi che manco gli intellettuali dei film degli anni ’60, quelli con la montatura degli occhiali spessa e i discorsi incomprensibili; è stressata; ha la pressione alta a trent’anni.
Nonostante questa variegazione di umori, o forse proprio per questo, fa fatica a capire dove sta il tasto per il riavvolgimento del cavo dell’aspirapolvere; si perde davanti al verso della griglia della cucina a gas; non azzecca mai la posizione della chiave nella serratura della porta di casa, avendo il 50% di probabilità: scritta a destra oppure scritta a sinistra.
E anche: spegnere la radio.
Basta un tasto.
Strappare il filo dalla presa, interrompe, sì, il flusso di musica e di parole, però fa saltare tutte le stazioni.
Casomai, la radio si può lasciare accesa.
Figuriamoci la lavatrice. Che ha un pannello di comandi che la fa assomigliare a una navicella spaziale e di cui anche io sto cercando di conoscere, libretto di istruzioni alla mano, alcune funzioni, evidenziate in giallo, complete di qualche appunto a matita: domandare al direttore dell’Experience.
Non si scappa. Tutti i SUV che vedo sembrano dei carri da morto. Che, almeno, sono fatti così perché hanno una funzione. Il SUV, invece, non si capisce.
Una volta da ragazza a una festa ho conosciuto uno che faceva l’autista per un’agenzia di pompe funebri. Era simpatico, caruccetto, chiacchierone.
Mi raccontò che quando era in servizio e aspettava, fuori dalla chiesa o fuori dal cimitero, lui si dava tanto da fare con sorrisi e frasette per abbordare le donne.
Che lo guardavano sempre storto e lui non capiva perché, visto che era simpatico e caruccetto.
Poi, casomai, te lo spiego.
Ho fatto Il Sorbetto d’argento, l’op. 50, quello che ha segnato le cinquanta settimane consecutive di Sorbetti, ci ho lavorato molto e poi l’ho rivisto due volte registrato.
Mi sembra venuto bene.
Volevo fare una cosa concettuale, riflettere sul tema dell’argento, numero atomico 47, simbolo Ag.

Il Sorbetto d’argento di Lorenzo Rocco
Sono passata per Primo Levi, che era un chimico e che ha scritto una raccolta di racconti che si intitola Il sistema periodico, mi sono fermata sull’Argento; sono andata a vedere il Rio della Plata (plata = argento); le monete antiche (il francese continua a chiamare argent il denaro); il cucchiaio d’argento con in bocca il quale nascono in inglese quelli che sono fortunati; il mio libro di ricette che Cucchiaio d’argento si chiama; ho indagato l’argenteria dei romanzi (quella del Gattopardo è definita da Tomasi di Lampedusa «massiccia»), quella delle case d’asta, quella dei musei e quella mia, che sta tutta in una scatola e di cui mi occupo personalmente, non facendola toccare a nessuno al di fuori dello spazio rituale della tavola; ho guardato le favole, Pattini d’argento e La monetina d’argento; ho citato la fotografia (stampa alla gelatina – sale d’argento), la lastre per le radiografie (medesimo procedimento); la luna, «Casta Diva che inargenti queste sacre, antiche piante».

La scatola della mia argenteria
Mi sono sfiziata, scapricciata, mi sono lasciata andare al soggetto, ho fatto sì che le immagini mi si presentassero e mi chiedessero di partecipare alla festa.
E festa è stata.
E adesso, come qualunque atleta in carriera che ha conseguito un primo risultato, guardo all’oro.
Non ho mai preso la Transiberiana. E forse nemmeno lui.
Anche se l’ha raccontata così bene.

Blaise
Blaise Cendrars, poeta e letterato di nascita svizzera che si è inventato un nome nuovo, che allude alla fenice favolosa che rinasce dalle proprie ceneri, che ha fatto (anche) una vita di miseria e (sempre) di avventura, racconta in un’epopea di quattrocento versi liberi che si intitola Prose du Transsibérien un viaggio su questo treno che attiene al mito.
Quando un giornalista gli chiese se lo aveva preso davvero, lui ha risposto: «Ma che te ne importa, visto che ve l’ho fatto prendere a tutti».
I versi sono un flusso continuo di pensieri, sono la velocità, il movimento e il sentimento di libertà, sono le donne, prima fra tutte Jeanne de France, giovane prostituta che lo accompagna e che gli chiede continuamente se sono lontani da Montmartre.
I versi sono un’invenzione poetica che trasforma le pagine scritte in viaggio straordinario e in modo per cambiare la propria autobiografia in leggenda.
A tutto questo si aggiunge l’interpretazione che ha dato del poema una grande artista, che ha segnato una tappa importante nella storia del libro, che di solito ha testo e immagini divisi.

Sonia Delaunay e Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien, 1913
Sonia Delaunay ha creato uno degli oggetti d’arte più belli che abbia visto in vita mia: una striscia lunga due metri, piegata a fisarmonica, nella quale i suoi colori si vanno a embricare con le parole.
Io, che sono così spesso di cattivo umore, devo ricordarmi di essere grata alla vita, o a chi per lei, per il mestiere che faccio, che a ogni momento mi scaraventa nella poesia, nelle immagini e in epopee fantastiche.
Lady of Abundance. Fra tutti i miei ormai prediletti vini del Sud Africa,
questo mi sembra di ottimo augurio.
Casomai mi passa pure l’umore cattivo.
Il mio bel vaso di rosmarino fresco mi ha dato l’idea di fare per cena delle pizze.
Bianche, condite solo con sale e olio.
E rosmarino.
Ho proceduto come da manuale di cucina.
Ho sgombrato e pulito col Cif tre volte in un pomeriggio il tavolo di marmo, che comunque pulisco di continuo.
Ho sciolto il lievito di birra nell’acqua tiepida, ho sistemato la farina a fontana, ho aggiunto il sale e ho cominciato a impastare.

Alexis Jordan, Rosemary plant (Rosmarinus rigidus), sec. XIX
Con i pesci che mi guardavano, gli occhi fuori dalle orbite, dalla parete della loro vasca.
(Mi chiedo sempre come sia casa mia vista da casa loro, una casa che sta in un’altra casa).
Ho fatto una palla di pasta, l’ho coperta e l’ho messa a riposare in un luogo protetto.
Certo che ho controllato almeno sei volte che succedeva: poco o niente, la pasta lievitava, ma in fondo mica era uno spettacolo.
Dopo tre ore ho steso la pasta rigorosamente a mano, ho prima infarinato e poi pulito nuovamente il tavolo.
Mi sono occupata della teglia.
Poi del forno. E qui credo che stia il problema. Il mio arriva al massimo a una temperatura di 300°, che per la pizza non basta, visto che un forno a legna di gradi ne raggiunge cinquecento.
Dunque, la pizza in casa è destinata a essere una cosa una tantum, mai riuscita del tutto, forse solo una specie di divertimento, oppure un’affermazione di qualcosa che al momento, dato il fastidio di tutta quella farina che andava dappertutto, mi sfugge.
Insomma, avere la mani in pasta è importante, sì.
Ma fino a un certo punto e, soprattutto, se la pizza te la mangi fuori e se tu ti occupi di altro.