
Francesco Giustozzi, Moulin Rouge!, 2001-2015
Che rabbia.
Mi fanno una rabbia.
Sto lì e provo continuamente un sentimento di rabbia, che, in fondo, è un bel sentimento.
Diverso e opposto alla rassegnazione, al vuoto tranquillo romano, al pantano nel quale da mesi affondo.
Ma non è solo rabbia, è anche invidia, è desiderio di partecipare, è l’allegria del rimbocchiamoci le maniche, è, a farla breve, vita che scorre impetuosamente e ti dice che l’arte sta tutta lì, a portata di mano, e che è importante, per tutti, non solo per quelli che ci lavorano dentro.
Voi prendete un museo piccolo, che so, il Musée de la Vie Romantique, che ho già citato a proposito di Madame Récamier e che, dice la mia guida, si visita in trenta minuti (per il Louvre ci vogliono, e non bastano, trent’anni).

Salon de Thé e serra, Musée de la Vie Romantique, foto MVR
Voi prendete un uomo che ti dà un appuntamento al Museo della vita romantica, nella serra del Salon de thé, non in un bar di piazza Mazzini.
Tutta un’altra musica, no?
Ci vuole così poco, a sedurre una donna.
Già residenza del pittore olandese Ary Scheffer, pavillon à l’italienne di epoca romantica a due piani, la casa è dotata di due atelier gemelli, entrambi orientati a nord.
In uno, si dipingeva.
Nell’altro, si riceveva.

Musée de la Vie Romantique, foto MVR
Mi sorprendo a pensare che mi piacerebbe vivere in un posto del genere e a fare due conti su quanto può venire a costare il personale di servizio.
Piuttosto, quanto ce ne vuole? Non è un castello, non è un appartamento.
Tutto è curato, tutto è accogliente, ci sono visitatori, giorno feriale, agosto, il giovane custode si sposta perché io possa scattare una foto della vista dalla finestra, sulle poltroncine, per indicare che non ci si può sedere, non ci sono i cordoni consueti ma delicati fiori secchi, è un museo di memorabilia, non di grandi capolavori, quindi si gode nell’insieme, passeggiando.
Tutto è catalogato con amore, tutto è raccontato con garbo.
Per esempio, la deliziosa scatola portapenne di legno, con il coperchio decorato da un’iscrizione fatta di piccoli brillanti color argento: ECRIVEZ MOI FOUVENT (sic), scrivimi spesso.

Scatola portapenne «Scrivimi spesso»
L’atto della scrittura diventa romantico.
(Va bene anche un WhatsApp, quando mi scrivi, mi fai contenta).
Sul cortile/giardino si apre il citato Salon de thé. Ci sono persone che leggono, altre che conversano.
- Musée de la Vie Romantique
- Prendimi per la gola
- Anche d’inverno si sta bene nella serra
Se non avessi un programma fitto fitto, se non fossi in trasferta di studio, quindi con il tempo contato e un elenco infinito di impegni, starei qui fino a stasera.
Che rabbia.
Al Grand Palais ho visto le mostre più belle e importanti della mia vita.
Una volta ho anche ottenuto il permesso per fare una visita guidata, ci ho lavorato mesi per organizzare tutto, viaggio, albergo, sopralluogo, permessi.
Mostra di Courbet.

Gustave Courbet, Autoritratto col cane nero, 1842
Prima di cominciare sono andata in bagno e mi sono guardata allo specchio. Non sono una tossica e non so quello che dico, ma mi sembrava di essermi mandata in vena qualcosa di molto potente.
Mi hanno appuntato sulla maglia un microfonino piccolo piccolo, sensibilissimo, è andato tutto bene, non ho incespicato nemmeno una volta, Courbet è, fra l’altro, uno dei miei pittori prediletti, sentivo che ce l’avevo nel sangue.
Per tre mesi mi è durata quella sensazione di sfinimento, la responsabilità, l’emozione, l’impegno.
Al Grand Palais organizzano anche corsi di storia dell’arte, fanno, cioè, quello che faccio io.
Corsi à la carte, per i curiosi, per gli appassionati, per le famiglie, per quelli che vanno di fretta, per gli studenti, per gli insegnanti che vogliono aggiornarsi. C’è anche il Festival Histoires d’Arts dal 10 al 21 giugno del 2020, ovvero c’è una selezione dei corsi, che si possono comporre comme un bouquet aux couleurs diverses, cioè come un mazzo di fiori tutto colorato.
C’è pure la pubblicità piena di luci in metropolitana.
Nel senso che: se vuoi provare a cimentarti con la storia dell’arte, cioè frequentarla, capirci qualcosa, trarre più benefici da un viaggio, dalla visita a una mostra, da un catalogo che sfogli la sera quando hai finito la giornata di lavoro e vuoi distrarti, qui ti vengono dati tutti gli strumenti.
Paghi una lezione € 20,00; un ciclo di 9 lezioni, € 140,00.
Ci sono tariffe ridotte e ci sono sconti, anche per l’acquisto di libri.
Che rabbia.
Il Louvre non è un museo simpatico.
Il rapporto delle attività pubblicato sul sito ci dice che nel 2018 è stato visitato da dieci milioni di persone, il 53% delle quali ha meno di 30 anni.
Però.
Con la chiusura di Notre-Dame dovuta all’incendio dello scorso mese di aprile, il flusso di presenze è aumentato ulteriormente.
D’accordo, è un museo monstre, che non andrebbe preso come esempio per via della commercializzazione violenta cui è sottoposto.
Ma contiene tesori d’arte imprescindibili, quindi io vado a studiarmi le mie circa dieci sale all’anno.
Questa volta avevo messo in calendario i nordici, fiamminghi e olandesi.
E loro che fanno? Spostano la Gioconda e la mettono nella sala 801, ala Richelieu, secondo piano.
Cioè, dove io volevo vedere Rubens.
E adesso, che faccio?
Niente, vado avanti.
Già la tessera di docente, Alta Formazione Artistica e Musicale, mi ha salvata da due ore di fila sotto il sole. Non solo l’addetto alla Sécurité cui mi sono presentata (io mi presento sempre, mi sembra corretto, e dico pure che sono onorata di essere loro ospite) mi ha aperto un cordone creandomi una corsia preferenziale, ma mi ha anche augurato «Bonne visite».
E io buona visita ho fatto.
Lei, la principale attrazione francese al mondo, forse la principale attrazione al mondo e basta, è sistemata benissimo, preceduta da cartelli poliglotti che dicono nella sostanza tutti vogliono vedermi, quindi tu datti una mossa, non puoi pretendere di stare davanti a me a contemplarmi.

Sala della Gioconda al Louvre
Ma, a contemplarla, nessuno ci pensa, tutti, piuttosto, si fanno un bel selfie, prova del loro viaggio sulla vetta artistica di Parigi.
I custodi, stoicamente, dirigono il traffico.
Vado a vedermi Rembrandt.
Vado a vedermi Vermeer. Il Louvre ha due suoi dipinti. Al mondo ce ne sono circa trenta, quindi la quantità è buona.
Provo l’ebbrezza della cattiveria.
Mi siedo e accanto a me c’è un gruppetto di italiane, tutte donne, mamma, figlia, zia, amica di non so chi.
Lombarde, mi pare.
L’intellettuale della compagnia, la ragazza, ha in mano una guidina del museo. Legge a voce alta, legge malamente, sbagliando gli accenti, con il tono monotono degli allievi che non capiscono quello che c’è scritto.

Johannes Vermeer, L’astronomo, 1668
Ogni volta che in aula faccio leggere uno studente, me ne pento.
Capisco i compagni che sbuffano.
La scheda, a orecchio, a me sembra fatta molto bene.
Il problema è che lei ha cominciato in ordine alfabetico, quindi da L’Astronomo, portando nel giro di poco allo sfinimento le compagne di viaggio.
Segni di insofferenza evidenti.
Comincio a pensare che dovrei suggerir loro di spostare gli occhi di trenta centimetri sulla sinistra.
Ma sono una che si fa i fatti suoi, e poi voglio vedere come va a finire.
Ma non è che queste sono così sceme da aver fatto due ore di fila sotto il sole; trenta minuti di attesa per la Gioconda; un altro pezzo di strada tortuosa per arrivare fino qui, e non calcolo nemmeno il viaggio, casa, aeroporto, aeroporto, albergo, e mancano il vero capolavoro del Louvre.
Sono sceme.
Esasperate, si alzano di scatto, sollevate dall’obbligo di ascolto e, come un sol uomo, se ne vanno.
Rimango in contemplazione del gioiello, dell’opera che, con tutto il rispetto, si mangia sia Monna Lisa che L’Astronomo.

Johannes Vermeer, La Merlettaia, 1669
La Merlettaia di Johannes Vermeer è un dipinto piccolo piccolo, grande poco più di una cartolina, che ritrae non un’operaia ma qualcosa di simile a un’artista, ripresa mentre è concentrata sul suo lavoro.
Opera intimista, tutta avvolta da una luce dorata, rivisita e porta all’apice un tema frequente nel pittore, quello di una giovane donna assorbita nella sua occupazione. Lei sta sistemando il gioco dei fuselli sul suo cuscino da ricamo, con il motivo della sua creazione tenuto fermo da spilli.
Lei è una cosa sola con il suo mestiere.
Alla nostra sinistra, da un cuscino à couture con le passamanerie più chiare, escono matasse di fili bianchi e rossi, che quasi scorrono come un ruscello sul tappeto dai motivi vegetali della tavola vicina.
Ben vi sta.
Hanno tolto la storia dell’arte dalle scuole e tutti ritengono che essa sia un inutile esercizio di stile.
Tu pensa quando le italiane in gita tornano a casa e, casomai fra qualche mese, raccontano di essere state al Louvre e il loro interlocutore dice «Ah, allora avete visto La Merlettaia».
Merlettaia, chi.
Pensa che rabbia.
Al Musée d’Orsay, questi, se stanno con le mani in mano un anno, si fanno venire il mal di pancia.
Hanno di nuovo modificato l’allestimento.
Facendo benissimo. Ora tutto è più chiaro. Come in un gigantesco gioco del 15 hanno spostato e rimesso tutto in modo diverso, con l’Impressionismo, che già da un po’ è salito tutto al quinto piano, inondato dalla luce che entra dalle vetrate che aprono sulla terrazza, che viene raccontato nei suoi esordi, nella sua fioritura e nel suo superamento.
Devi essere proprio stordito, per non capire lo svolgimento.
I francesi sono cartesiani e lo dimostrano ancora una volta, pervenendo a una narrazione lucida e impeccabile dei loro artisti di punta.

David Wilkie Wynfield, Edouard Manet, 1868
Con questo criterio Manet sta un po’ sopra e un po’ sotto, come è giusto.
Guardate com’era bello, qui lui ha trentasei anni.
Guardate che seduzione, e che eleganza.
Nel mio viaggio di studio dello scorso anno gli ho dedicato un’intera giornata, che ho raccontato qui.
Tutto il museo è percorso da un filo conduttore, è, come sempre, pieno di gente e pieno di iniziative, ci sono mostre, concerti, ristoranti, l’esposizione di Berthe Morisot è magnifica, chi è quello scemo che ha sostenuto più di una volta che le donne degli Impressionisti sono meno potenti, sempre interessate a deboli soggetti femminili.
Lo scemo sono io.
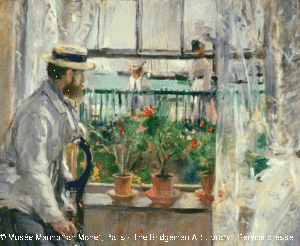
Berthe Morisot, Eugène Manet all’Isola di Wight, 1875
Devo farmi perdonare, prometto di passare la prossima stagione a togliere di mezzo questa stupidaggine, lei è una meraviglia, oggi mi viene pure da pensare che lei sia la più brava del gruppo.
C’è anche una sezione dedicata a un’artista contemporanea da me prediletta: Tracey Emin, sempre confessionale, è stata invitata a scegliere dai disegni delle collezioni del Musée d’Orsay quelli che desidera far dialogare con i disegni suoi.
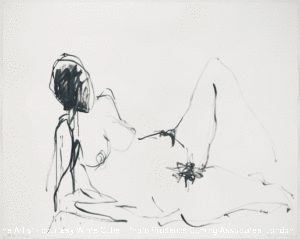
Tracey Emin, Paura d’amare, 2018
Il disegno, ovvero la forma più fragile dell’arte, quella «più vicina ai sentimenti e all’intelletto».
Il risultato è, come sempre con lei, coinvolgente e lacerante.
I suoi nudi esprimono la nostra gracilità di esseri umani messi di fronte all’amore, tutto l’amore, per un uomo, per un oggetto, per un animale.
Lei mi entra come un coltello nel cuore, rende la mia visita aggiornata, nuova, fresca, voi sapete, mia madre diceva pezzo da museo per indicare una cosa obsoleta, magari non lo sapeva fino in fondo, però l’intenzione era quella.
Ecco, qui l’espressione cambia completamente di segno.
Mai che da noi si veda una cosa del genere.
Che rabbia.
In hotel, ho già raccontato che ho trovato dei libri.
Questo stava nel bar, appoggiato su una mensola di vetro, tutto illuminato, l’ho visto subito, per il formato quadrato 12 x 12 e per il filo delle pagine d’oro.

Francesco Giustozzi, 50 décors 50 films à deviner, 2015
Scintillava.
Il succo: ci sono cinquanta disegni di décor, che è un concetto che corrisponde alla scena, al suo arredo e a tutto quello che noi, poi, vediamo sullo schermo, di cinquanta film.
L’invito è a indovinare, la soluzione sta nelle pagine finali.
Disegni accurati, poetici, leggiadri, con dentro una conoscenza intima e profonda del cinema, un’infinita delicatezza e, soprattutto, un’idea.
E un’intuizione, quella che un’illustrazione possa evocare tutto un mondo, già di per sé incantato, ma che in questo modo diventa magico.
Mi sono sfogliata tutto il libro, sentendo montare in me il sentimento di rabbia.
Ma guarda tu questi francesi, quanto sono bravi, sono davvero irraggiungibili, oltre alla stanza e al bar pieni di suggestioni, anche il libro giusto per godersele.
Ho guardato l’autore, raccontato brevemente nell’introduzione: design, illustrazione, moda, libri, web, anche giocattoli.
Chi è e dove vive.
Francesco Giustozzi è italiano e vive a Macerata.
Se dovesse lasciare la sua città, «sarebbe per sistemarsi a Notting Hill, come nel film, o presso Mrs. Doubfire, perché San Francisco lo fa sognare».
Un italiano.
Ci ho riso sopra mezz’ora.
Allora c’è speranza, allora pure da noi c’è talento, allora la partita non è ancora chiusa.
Ho cercato l’artista, oggi i social sono un grande aiuto immediato, gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto squisitamente.
I clienti dell’albergo sono pregati di non portarsi via i libri ma di andarseli a comprare nella libreria Les Arpenteurs, altra collaborazione di quartiere.
Ci vado la prossima volta. E poi volevo quella copia lì.
Dunque, ho chiesto al giovane direttore dell’hotel di mettermela sul conto.
E gli ho raccontato la mia cantonata, gli ho detto che, accecata dall’ammirazione per la loro cultura, avevo subito pensato che essa avesse generato anche quel gioiello.
Invece no, è farina del nostro sacco.
Insomma, è il frutto dell’ingegno italiano, quello che ha prodotto una civiltà senza confronti, nella quale primeggia da sempre l’arte.
Pensa, i francesi, i nostri simpatici cugini d’Oltralpe, che rabbia.

Francesco Giustozzi, Fino all’ultimo respiro, 1960-2015


